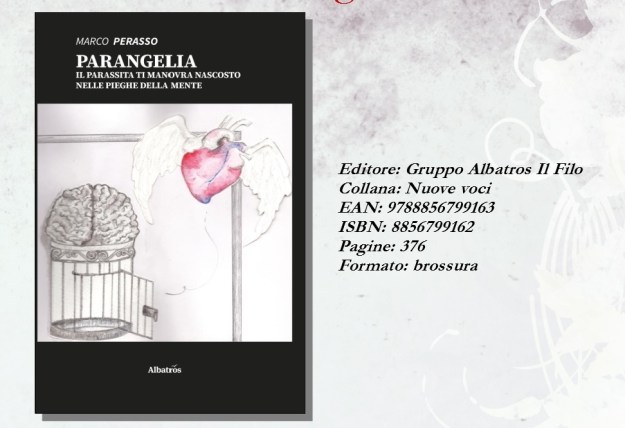La potenza è nulla senza controllo.
Così recitava un famoso spot della Pirelli di molti anni fa, un tormentone pubblicitario rimasto nella storia.
Avere il controllo della situazione ci tranquillizza, e tutti ne andiamo alla ricerca. Ma cosa significa esattamente? E fino a che punto è possibile averlo?
Nella lingua inglese il verbo controllare possiede almeno due traduzioni dai significati molto diversi:
- to control, che significa comandare, regolare, dominare, governare, manovrare;
- to check, che significa verificare, spuntare, monitorare.
Esistono poi molte altre traduzioni dai significati più specifici, tutti riconducibili a queste due categorie più generali.
Partiamo dalla prima: credi veramente che sia possibile avere il dominio sul mondo che ti circonda? A mio avviso questa è la più grande illusione e fonte di frustrazione dell’essere umano, ben evidente a chi è genitore.
Molti vorrebbero avere una vita con certe caratteristiche, e da un lato si piangono addosso perché la realtà è alquanto diversa, dall’altro si affannano in un perenne inseguimento di qualcosa che sfugge di mano.
La verità è che tu non hai il dominio sulla freccia, una volta che è scoccata: puoi metterci tutto l’impegno, la concentrazione, la perizia, la forza di volontà… ma una volta che apri le dita, devi accettare il fatto che miliardi di altri fattori andranno ad influenzare la direzione del dardo, e da quel momento avrai perso il tuo potere. E la vita è un susseguirsi di frecce scagliate, migliaia di azioni che compi quotidianamente il cui esito non dipende esclusivamente da te.
Beh, obietterai tu, d’accordo, ma almeno fino a che sto tendendo l’arco posso ben dire di avere il controllo, almeno questo mi rimane.
Ne sei proprio sicuro? Sei davvero sicuro di avere il dominio sul bersaglio che hai (o pensi di avere) deciso di colpire? Oppure anche questo va al di là dei tuoi margini di manovra? Fino a che punto puoi modificare il tuo battito cardiaco, il tuo respiro, il tuo sistema immunitario, il tuo sistema endocrino? Fino a che punto puoi tenere a bada le tue emozioni, che dei primi sono manifestazione? Fino a che punto puoi manovrare le tue reazioni istintive quando un pericolo ti minaccia, o più semplicemente quando un automobilista di taglia la strada, o qualcuno ti insulta? Fino a che punto gli obiettivi che ti affanni ad inseguire sono stati davvero decisi da te?
Se lasci da parte per un momento le manie di grandezza e ti osservi nei comportamenti quotidiani con la sufficiente dose di umiltà ed onestà intellettuale, dovrai convenire con me che neppure su questo hai il controllo: ti comporti per la maggior parte del tempo come un automa in balia degli eventi, esterni o interni a te.
Cosa rimane, dunque? Rimane per l’appunto quella che ha condotto a questa presa di coscienza: l’osservazione. Rimane l’altra accezione del verbo controllare, la costante verifica di ciò che sta accadendo, quella che in economia aziendale prende il nome di controllo di gestione: una attenta ed imparziale analisi degli scostamenti su ciò che è e ciò che doveva essere, una comprensione a posteriori di ciò che è accaduto.
To check.
Sembra poco, ma è la base per l’auto consapevolezza. Ed è solo con questa che puoi comprendere come funzioni, i tuoi automatismi, i tuoi vincoli interiori.
Mi dirai: tante grazie, ma una volta che ne ho preso atto, a che mi serve? Che me ne faccio, se poi tutto accade in maniera meccanica?
Beh, non aspettare una risposta che non ti posso dare… prova sulla tua pelle. Per quanto mi riguarda, posso dirti che l’auto consapevolezza (le poche volte che riesco a raggiungerla) modifica alla base le leve che muovono i miei automatismi, ed in questo senso mi dà maggior padronanza della situazione, seppur indirettamente; è un po’ come hackerare il sistema, per dirla in gergo informatico: io rimango un automa che risponde meccanicamente, ma cambiando alla fonte i dati in ingresso anche l’output prodotto è diverso.
Ma chi sono io per dire che funziona così anche per te? Mica ho il controllo… prova, e fammi sapere.